Didascalia
La didascalia è un insieme di informazioni verbali che integra le informazioni visive di un’immagine.
Una didascalia può riferirsi all’aspetto formale, al suo contesto, al suo significato.
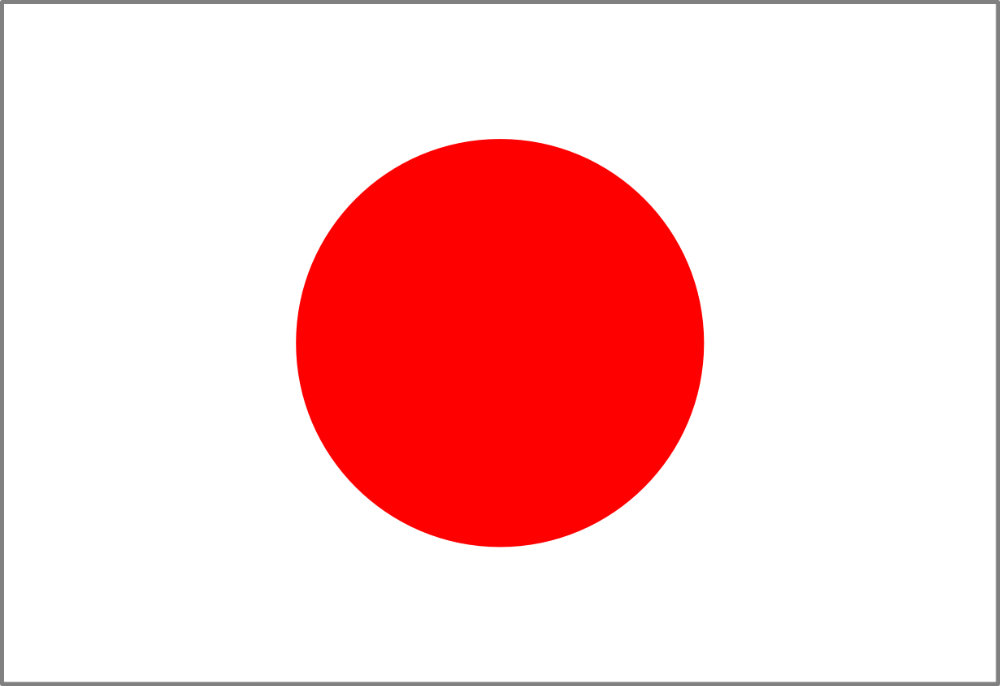
La didascalia formale è “cerchio rosso su fondo bianco”.
“Bandiera giapponese” contestualizza l’immagine: non è una semplice figura geometrica, è la bandiera che il Giappone ha adottato fin dal 1860.
“Hinomaru, che in giapponese significa “cerchio del sole”, è il nome della bandiera del “paese del sol levante”, ed è una stilizzazine del sole che sorge dal mare” è una didascalia che ne spiega il significato.
La didascalia corrisponde al titolo di un quadro, di un film, di un romanzo, di una poesia, o alla marca e all’etichetta di un prodotto.
La combinazione fra immagini e parole è antica quanto la capacità dell’uomo di esprimersi con immagini analoigiche e parole simboliche. Probabilmente le pitture di Altamira o di Lascaux servivano a sciamani e capi per parlare di animali, di cacce, di rituali magici, evocandole nelle caverne alla luce intermittente di torce e focolari.
L’immagine da sola non basta ad esprimersi con chiarezza, perché spesso è ambigua, o generica, o non riferibile ad esperienze acquisite. In questi casi qualche parola può bastare a chiarire i dubbi e a dare quel minimo di informazioni che aiuta a comprendere e classificare l’immagine in modo corretto. La parola da sola può non riuscire a mostrare la bellezza do un volto o di un paesaggio, o la struttura di un edificio.
La didascalia deve rispondere alla domanda: che cos’è quello che vedo? Allo stesso modo l’immagine deve rispondere alla domanda: com’è quello che leggo o che ascolto? Quando guardiamo qualsiasi cosa ci poniamo la domanda, anche solo col pensiero: che cosa sto vedendo? Quando leggiamo e ascoltiamo, cerchiamo di immaginare com’è il personaggio del racconto, o il luogo in cui si trova. Useremo parole e immagini per fare in modo che chi riceve il nostro messaggio sappia e veda ciò che noi vogliamo fargli sapere e vedere.
Per semplificare consideriamo come “didascalia” qualsiasi tipo di informazione verbale abbinata ad un’immagine, dal semplice titolo fino ad una articolata e ampia scheda di commento.

Partiamo da questa immagine e vediamo quante e quali didascalie possiamo aggiungervi.
1. “Napoli – Panorama e Vesuvio”. Questa è la didascalia presente nell’immagine, e ci informa che si tratta di una veduta panoramica di Napoli.
2. “Cartolina postale”. Questa è un’informazione che potremmo aggiungere noi, precisando che non è l’illustrazione di un libro, ma una cartolina.
3. “Cartolina postale da collezione degli anni ’50”. Questa didascalia colloca meglio l’oggetto “cartolina” nel contesto culturale di collezionismo vintage.
4. “Veduta di Napoli da Posillipo, con il pino marittimo, il monte Somma e il Vesuvio, la riviera di Chiaia e Castel dell’Ovo”. In questo caso aggiungiamo informazioni che riguardano i contenuti dell’immagine.
Potremmo andare avanti nel descrivere le forme di insediamento urbano, le caratteristiche botaniche del pino, l’iconicità dell’immagine che per antonomasia rappresenta Napoli, e così via.

Questa immagine è simile alla precedente. Vediamone le didascalie.
1. “1167 Napoli – Panorama”. Questo è il titolo dell’immagine. Il numero si riferisce ad una catalogazione delle foto di Giorgio Sommer. La didascalia aggiunge solo il nome della cittàall’informazione tautologica (“panorama” per definire un panorama).
2. “Napoli tra ottocento e novecento, panorama visto da Posillipo”. Questa didascalia aggiunge l’epoca della foto e il punto di ripresa.
3. “Giorgio Sommer, veduta di Napoli anteriore al 1914 con il Vesuvio attivo. Panorama da Castel Sant’Elmo a sinistra a Castel dell’Ovo a destra”. Qui le parole ci informano sull’autore della foto, identificano il tratto di città fra i due castelli, e richiamano l’attenzione sul pennacchio di fumo che esce dalla cima del vulcano e sulla forma appuntita della cima del cono rispetto alla forma attuale più arrotondata.
Potemmo procedere dicendo che non è stata ancora fatta la colmata della riviera di Chiaia, che la foto fa parte delle numerose riprese fatte da Giorgio Sommer, fotografo italo-tedesco morto nel 1914, e dedicate a Napoli, Pompei, Ercolano e dintorni vari, che il Vesuvio era ancora attivo perché l’ultima eruzione avvenne nel 1944.

Questa è una cartolina della piazza del Gesù Nuovo, sempre a Napoli. Eccone le didascalie.
1. “Napoli, Piazza del Gesù Nuovo”. Se si tratta di una cartolina postale, questa didascalia è sufficiente.
2. “Napoli, la Guglia dell’Immacolata nella piazza del Gesù Nuovo”. La didascalia focalizza sulla guglia settecentesca come protagonista dell’immagine.
3. “La Guglia dell’Immacolata davanti al Palazzo Pignatelli di Monteleone”.
A questa didascalia si potrebbero aggiungere altre informazioni sulla famiglia Pignatelli di Monteleone e sul pittore Edgar Degas che abitava e dipingeva lì nei suoi soggiorni napoletani, ospite del nonno banchiere che lo aveva acquistato. E si potrebbe aggiungere che ora nel palazzo c’è l’hotel Maison Degas proprio in ricordo del maestro impressionista.

La foto della stessa piazza non ha la distaccata rappresentatività della cartolina, ma presenta un momento di vita napoletana in cui guglia e palazzo fanno da scenario, non da protagonisti.
La didascalia potrebbe essere “Napoli anni ’50, un lustrascarpe per strada“. La Fiat 500 è stata prodotta dal 1956 in poi, quindi la foto è della fine degli anni ’50. Il lustrascarpe fa parte dei mille mestieri tipici dell’arte di arrangiarsi napoletana. Queste informazioni possono essere aggiunte per far “parlare” le immagini.
La didascalia dipende dall’uso dell’immagine. Se uso una foto per una cartolina, mi basta dire dove siamo. Se la uso per un depliant turistico, darò informazioni culturali, climatiche, ambientali. Se la uso in un saggio scientifico parlerò della forma del vulcano o del tipo di insediamento urbano. Da questi usi molteplici dipende sia l’informazione che la disinformazione, quando la didascalia contribuisce a deconestualizzare l’immagine e ad usarla per altri scopi.
Se le immagini vengono usate in un servizio giornalistico, oltre che con la didascalia interagiscono anche con titoli e sottotitoli. Ecco la stessa immagine in due contesti editoriali diversi.

L’immagine di sinistra potrebbe essere presentata in un redazionale o in un sito turistico come la foto di escursionisti che approfittano del bel tempo per fare una bella sgambata nella neve. L’immagine di destra potrebbe essere confezionata in un articolo o un sito di una testata sovranista come testimonianza di clandestini che affrontano incontrollati i rigori dell’inverno pur di passare la frontiera.
Vediamo ora alcuni titoli di opere d’arte famose, che aggiungono elementi di riflessione sul rapporto fra parole e immagini, a volte didascalico ed esplicativo, altre volte stimolante e paradossale.
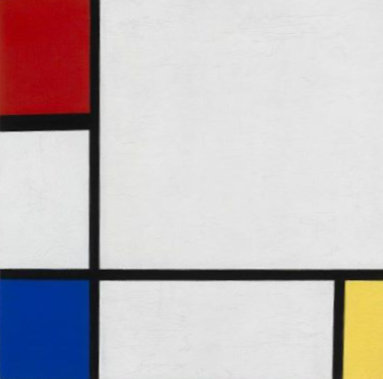
“Composizione con rosso, giallo e blu“. Tra il 1920 e il 1922 Mondrian fa una serie di composizioni con perpendicolari nere su fondo bianco e riquadri con colori primari, e le intitola tutte “composizioni”, per ribadire il concetto che la pittura non deve rappresentare altro che se stessa. Mondrian ci vuole dire che il suo quadro non è “altro” che una composizione in bianco e nero con i colori primari rosso, giallo e blu, e cioè l’immagine a colori più semplice ed essenziale che si possa concepire.
Specialmente nell’arte non figurativa sono frequenti i titoli che anche nelle parole evitano qualsiasi riferimento a contenuti concreti, come “senza titolo“, “composizione“, “quadro con cornice bianca” o “Intersezione” di Kandinsky, fino al suprematista Kazimir Malevič, che nel 1918 dipinge “Quadrato bianco su fondo bianco“, arrivando al limite in cui non si può raffigurare e dire meno di così!
Anche nella musica abbiamo titoli evocativi come quelli di Debussy (il mare, le sirene, la cattedrale sommersa, giardini sotto la pioggia) o aride indicazioni come i titoli di Mozart (Concerto per piano n. 21 in Do maggiore K 467, che indica la forma musicale, lo strumento solista, la tonalità, il numero del catalogo cronologico di Köchel).

Dadaisti e surrealisti sono stati molto creativi anche nel dare i titoli alle loro opere. “Le violon d’Ingres” è una foto fatta da Man Ray nel 1924, con la famosa Kiki de Montparnasse, al secolo Alice Ernestine Prin, sua modella ed amante, inquadrata di spalle come le odalische di Ingres, con le effe del violino attaccate sul dorso. La foto è stata venduta alla cifra record di 7 milioni di dollari in un’asta di Christie. Il titolo offre una chiave di lettura dell’opera, richiamando alla mente Ingres e trasformando il nudo in un oggetto misterioso dalle forme armoniche del violino che richiamano i fianchi femminili.

“Le cadeau” è una scultura realizzata da Man Ray nel 1921. Anche in questo caso il titolo dà una chiave di lettura dell’opera. La fila di chiodi rende inutile un oggetto di comune utilità come il ferro da stiro, e quindi ne fa un oggetto estetico, non più da usare, ma solo da godere. Come un dono, le cadeau.

Ma l’abbinamento più intrigante fra immagine e parola è senza dubbio la pipa di René Magritte. La pipa è dipinta con pedante realismo, ma in modo altrettanto pedante Magritte ci avverte che “ceci n’est pas une pipe” (questa NON è una pipa) con una scritta infantile dipinta con lo stesso stile dell’immagine. La didascalia quindi diventa parte integrante del dipinto, si fa essa stessa dipinto, ma per negarne la rappresentatività figurativa. Il paradosso mette in evidenza l’impossibilità di negare del linguaggio analogico (il linguaggio visivo) contro la capacità di negare del linguaggio digitale (il linguaggio verbale), e la contraddizione fra la percezione sensoriale emozionale (l’occhio) e l’elaborazione razionale (il cervello). L’occhio continua a vedere una pipa, ma il cervello avverte che non si tratta di una vera pipa, ma di una sua rappresentazione.
Il filosofo Michel Foucault ha dedicato un intero saggio a quest’opera, dove dice: “… paragonato alla tradizionale funzione della didascalia, il testo di Magritte è doppiamente paradossale. Si propone di nominare ciò che, evidentemente, non ha bisogno di esserlo (la forma è troppo nota, il nome troppo familiare). Ed ecco che nel momento in cui dovrebbe dare un nome, lo dà negando che sia tale.” E osserva che Magritte è impegnato a “separare scrupolosamente, crudelmente, l’elemento grafico dall’elemento plastico: se ad essi accade di trovarsi sovrapposti all’interno del quadro, come una didascalia e la sua immagine, è a condizione che l’enunciato contesti l’identità esplicita della figura e il nome che si è pronti a darle”, altrimenti si tratterebbe di una troppo banale tautologia che nulla aggiunge a ciò che già si sa.

Il problema dell’interazione fra parola e immagine è spinto all’estremo concettuale con l’installazione “Una e tre sedie” di Joseph Kossuth del 1065, esposta al MOMA di New York. L’opera è composta da una sedia pieghevole in legno, dalla sua foto in bianco e nero eseguita con le stesse condizioni di luce, e da un pannello con l’ingrandimento della definizione della parola “chair” (sedia) tratta da un vocabolario. I tre elementi hanno uguale importanza, e vanno visti insieme. Anche qui la descrizione verbale fa parte dell’opera, e assumendo la forma della definizione lessicale diventa la didascalia per antonomasia, buona per qualsiasi sedia. Il titolo stesso dell’installazione, apparentemente banale e tautologico, ci dice che stiamo guardando una sedia (l’oggetto di legno) ma al tempo stesso tre espressioni del concetto di “sedia”: il suo referente oggettivo, il suo significante iconico (la foto), il suo significante verbale (la parola con la sua definizione lessicale).
Il lavoro di Joseph Kosuth indaga le relazioni che intercorrono fra le cose, le loro immagini e le parole che le definiscono. Le sue opere annullano gli oggetti, sostituendoli con le idee di essi. Questa installazione, in cui manca ogni componente di natura emozionale anche per la luce uniforme dell’ambiente, non cerca di suscitare un godimento estetico. vujole solo stimolare l’attività del pensiero. Qualunque oggetto ha una sostanza reale, un’immagine e un nome. Di fronte ad una sedia ci viene spontaneo pensare al suo nome e alla sua immagine, nel momento stesso in cui percepiamo la sua presenza materiale. Tuttavia l’artista ha voluto evidenziare la grande distanza concettuale fra un oggetto reale, una sua riproduzione per quanto fedelissima, e la sua definizione verbale. La realtà in cui viviamo è sempre ben diversa dalla sua rappresentazione attraverso il linguaggio, sia esso verbale, figurativo o fotografico.

